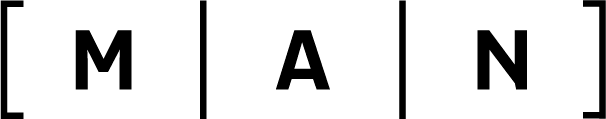una produzione MAN, Nuoro
da un’idea di Chiara Gatti
testi scientifici a cura di Andrea Nante e Paolo Campiglio, Serena Colombo e Chiara Gatti
Coordinamento di Rita Moro
Il museo MAN di Nuoro presenta un progetto inedito dedicato a un dialogo ideale fra passato e presente, fra classico e contemporaneo, in linea con una filosofia espositiva che da anni conduce riflessioni sull’eterno ritorno di temi universali nell’arte di tutti i tempi.
Dopo le grandi mostre già riservate ad Alberto Giacometti e l’arcaico (in collaborazione con la Fondazione Giacometti di Zurigo) o Picasso e il mito, nella serie celeberrima delle incisioni per la Suite Vollard, il MAN intende indagare il nesso che, a distanza di secoli, collega la ricerca spaziale di Lucio Fontana con il valore dello spazio nelle composizione di Giotto, unitamente alla presenza fortemente simbolica del colore oro nella sua reificazione dell’infinito e dell’altrove.
Nella tradizione pittorica bizantina e in quella medievale occidentale, viene progressivamente meno la volontà di rappresentare uno spazio reale e tridimensionale. Il fondo oro di mosaici e tavole dipinte offre infatti una rilucenza profonda e vibrante e conferisce alla composizione pittorica, per lo più sacra, un’aura di religiosità e mistero, atta a sancire il legame indissolubile tra arte e fede.
Il dipinto è un’icona da adorare e assume un valore simbolico, alludendo a valori eterni e trascendenti.
Giotto, Due apostoli, 1325-1330 Tempera e oro su tavola Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Galleria di Palazzo Cini
L’oro non è colore, ma simbolo divino, esalta le figure, ieratiche e bidimensionali, senza umanizzarle, le astrae dal contesto reale, isolandole nel tempo e nello spazio e le pone entro rigidi schemi fissi, annullando ogni consuetudine e ogni rapporto con la quotidianità: nessuna espressione e movimento, nessun paesaggio familiare, nessun edificio riconoscibile, nessun riscontro con il vissuto.
Un nuovo senso della realtà e dello spazio, vero e profondo, emerge nell’arte medievale grazie alla personalità di Giotto (1267 ca.-1337), che già i contemporanei lodavano poiché «rimutò l’arte di greco in latino e la ridusse al moderno», come scrisse Cennino Cennini nel suo Libro dell’Arte. Lo spazio sacro e dorato, bidimensionale e trascendente, cortina di luce che isola dal mondo esterno della tradizione precedente, viene “bucato” da Giotto, alla ricerca di una terza dimensione, profonda e reale.
Il fondo oro diventa cielo vero, atmosferico, lucente e terso nelle giornate di primavera, illuminato dalla luce della luna e delle stelle (e persino delle comete) nella notte buia.
Giotto scopre come la pittura possa raffigurare ciò che l’occhio vede, comprese la possibilità dell’illusione, meravigliosamente sperimentate per la prima volta nei due celebri finti coretti della cappella degli Scrovegni di Padova. Qui, all’inizio del Trecento, ancor prima dell’invenzione della prospettiva rinascimentale, Giotto introduce l’idea del trompe-l’oil, della pittura capace di trasformare lo spazio e creare ambienti illusionistici. Uno spazio senza figure e in cui – senza preavviso – irrompe il mondo esterno. I due fini vani, vuoti, potrebbero animarsi da un momento all’altro di cantori. E, dalla bifora gotica, si potrebbero vedere le rondini volteggiare nell’aria, dalla gronda della vicina chiesa degli Eremitani, come scrive Roberto Longhi nel 1952.
“Giotto spazioso” è la definizione che il grande critico suggeriva per questo nuovo modo di pensare alla pittura, spiegando, a proposito della cappella padovana, che «per chi, ora, si collochi al centro del pavimento della cappella, e cioè nel luogo più adatto ad abbracciare con un solo sguardo la parete in cui si apre l’abside, torna sùbito chiaro, palmare, sensibile fino all’illusione che i due finti vani “bucano” il muro, mirano ad intervenire nell’architettura stessa del sacello. All’effetto di veridica illusione convengono le due volte gotiche concorrendo ad un solo centro che è sull’asse della chiesa e cioè nella profondità ’reale’, esistenziale dell’abside; conviene la luce interna che, partendo dal centro, si diffonde inversamente nei due vani, persino sulle colonnine e sugli stipiti delle due bifore; conviene la luce esterna di celo che colma l’apertura delle bifore stesse: non di un oltremarino “astratto”, ma di un azzurro biavo, che si accompagna a quello (vero) fuor delle finestre dell’abside».
Ma anche nei fondi oro – pensiamo alla giovanile Madonna di Borgo san Lorenzo e a quella di San Giorgio alla Costa o alla più tarda Maestà di Ognissanti – il cielo metafisico non è più infinito e, al tempo stesso indefinito, bensì fisico e reale. Le figure sono robuste come sculture e nel fondo, pur dorato, circola l’aria. Concorrono all’introduzione della realtà nella pittura l’uso della luce, di cui Giotto individua sempre la fonte, che modella i volumi, occupa lo spazio rendendolo plausibile e ‘naturale’. Abitabile. Concorrono le intuizioni con cui il maestro coglie le relazioni tra luce e colore (il colore muta, a seconda del variare della luce, non solo di intensità ma di qualità), il suo approccio inedito alla quotidianità della vita, nella resa curiosa di espressioni, oggetti, e della natura, come un obiettivo spalancato nuovamente sulla realtà, in ogni suo aspetto, dai più sacrali ai più umili, riproposto nella verità degli spazi architettonici e paesistici. Proprio in questa riappropriazione della realtà, al di là degli schemi della tradizione, la vita, lo spazio, l’uomo e i suoi sentimenti tornano a essere protagonisti della pittura. Un approccio vivo e rivoluzionario attuale anche per la pittura moderna e contemporanea, che tanto debito nutre nei confronti del suo pensiero.
«Le condizioni fondamentali nell’arte moderna sono chiaramente evidenti nel XIII secolo, in cui inizia la rappresentazione dello spazio», scriveva Lucio Fontana nel suo «Manifiesto Blanco» del 1946. Con l’artista di Santa Fè, lo spazio nuovo e illusorio di Giotto si trasforma infatti in uno spazio realmente tridimensionale. La luce che lo attraversa rende palpabile il principio della soglia, dell’affaccio, del luogo di confine fra visibile e invisibile, secondo altresì l’antico concetto di iconostasi che Fontana rilegge nella sintesi radicale del suo gesto. La luce irrompe dunque in uno spazio mentale rendendolo improvvisamente percorribile. È proprio la stessa luce che, nei fondi oro del Trecento – così come analizzata fra le pagine de Le porte regali di Pavel Florenskij – vedeva una materializzazione dell’immateriale e che ha poi attraversato i “concetti spaziali” di Lucio Fontana, accarezzandone sabbie, pietre, pezzi di vetro e foglie d’oro. Una luce dilagante e calda, ma generata da un atto pittorico.
Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960-61
Olio su tela
MART, Museo di arte moderna e contermporanea di Trento e Rovereto
Collezione Domenico Talamoni
Il dialogo proposto in mostra fra una preziosa tavola di Giotto – i Due apostoli della Fondazione Giorgio Cini di Venezia – e un Concetto spaziale di Fontana del MART di Rovereto – attinge, oltre che alle speculazioni di Florenskij, a una lunga letteratura concentrata su corsi e ricorsi di quella magnifica ossessione della pittura per la rappresentazione dell’assoluto, affrontata scientificamente da grandi studiosi, fra cui Georges Bataille, Lionello Venturi, Jean-Paul Sartre, Michael Baxandall, Jean Servier, Luigi Carluccio. Una tensione verso l’infinito e il trascendente accomuna antichi e contemporanei e rende il dialogo fra Giotto e Fontana significativo e puntuale nel senso di un affondo esemplificativo, minimalista quanto intenso, fra le pieghe di questo tema di studio dell’arte universale. La pittura delle icone presuppone, non a caso, una metafisica delle immagini e della luce che nel Novecento trova eredi sensibili. Ed è a questa metafisica che autori come Wildt, Carrà, Casorati e poi Melotti e Fontana, oltre a maestri internazionali del calibro di Rothko o Yves Klein, hanno guardato, rivolgendosi persino all’uso dell’oro come veicolo verso l’astratto, verso il sacro, oltre le “porte regali” dell’iconòstasi, al di là del margine fra mondo visibile e il mondo invisibile, «luogo dove si manifesta una pittura sublime – per citare Florenskij – in cui le cose sono “prodotti della luce”».
«Scoprire il Cosmo – ripeteva, non per nulla, Lucio Fontana – è scoprire una nuova dimensione. È scoprire l’Infinito. Così, bucando questa tela – che è la base di tutta la pittura – ho creato una dimensione infinita».
Foto allestimento: Alessandro Moni