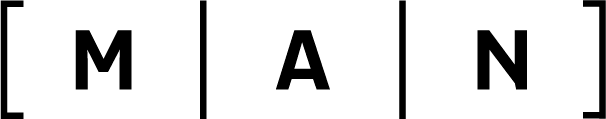Parole e telline
«Le parole sono importanti» urlava Nanni Moretti in una celebre sequenza di Palombella rossa, schiaffeggiando (ma oggi si potrebbe fare ancora?) la giovane giornalista che lo intervistava usando un linguaggio colloquiale sbrigativo e parole inglesi di basso profilo.
La parola esatta – che rappresenta un vero privilegio del nostro comunicare col mondo – dovrebbe essere valorizzata e rispettata anche dalla critica d’arte dove l’affollamento di neologismi figli di internet e della cultura social si alternano a prodezze linguistiche studiate per elevare il discorso a livelli volutamente inaccessibili. Cosa che, in epoca di politiche di accessibilità, è quanto meno bizzarro.
Tipico di atteggiamenti distorti e distorcenti, l’uso di parole ermetiche genera superfetazioni mirate ad abortire la disdegnata ma buona pratica della divulgazione, per escludere dal discorso e non includere nella conoscenza condivisa. Se da un lato il livello del linguaggio generale tende infatti sempre più al povero (al “cheap” direbbe la giornalista di Moretti incassando il secondo ceffone…), dall’altro lato la manipolazione intellettuale è il frutto succoso di una cultura che punta all’apparenza e non alla sostanza.
Ne è un esempio recente il progetto scientifico della nuova Biennale di Architettura di Venezia siglato dall’ingegnere e architetto torinese Carlo Ratti (classe 1971) che, passato dal Politecnico di Torino al MIT di Boston, ha sfoggiato per la sua Biennale il titolo Intelligens. Natural. Artificial. Collective, estrapolando poi dal participio latino intelligens (derivato da intelligere) un improbabile gens, cioè popolo, considerandolo un sostantivo a parte, piegato pretestuosamente alla sua esigenza di parlare di umanità, invece di rispettare l’origine semantica corretta di “intus-legere”, ovvero “leggere dentro”, dunque, capire.
Un gioco di parole e di grafia, insomma, che denuncia una tendenza funambolica di certa critica odierna, votata alla superficie e non al senso, alla mistificazione e non alla precisione. «Un linguaggio il più preciso possibile – diceva Calvino nelle sue belle Lezioni americane – come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e dell’immaginazione».
Sul binomio perfetto leggerezza-esattezza si regge tutto il meraviglioso cosmo della nostra lingua, che proprio con la leggerezza si eleva. Per difendersi dalle elucubrazioni narcisistiche basterà allora un qualsiasi passaggio del grande critico Roberto Longhi, famoso per le sue descrizioni cristalline, come quella della Natività di Caravaggio e del suo «bambino miserando, abbandonato a terra come un guscio di tellina buttato». Parole leggere per immagini esatte.
Chiara Gatti