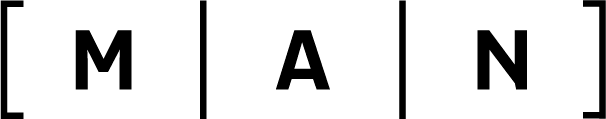Involuzione digitale
Proliferano i bandi dedicati all’utilizzo delle nuove tecnologie per aumentare virtualmente l’esperienza-museo. Portali virtuali interattivi, connessioni audio-video in streaming, network, QR code, link, zoom, meet, realtà aumentata e intelligenza artificiale come se piovesse materia grigia dall’etere in ogni misero angolo del nostro pianeta.
Noi, come museo, ci siamo impegnati in questi anni a partecipare a ciascuno di tali progetti innovativi, sviluppando i “famosi” ambienti immersivi, usando AI per ricreare luoghi, opere e animali, incrementando il sito con visite 3d, abituandoci a parlare quotidianamente di media, social, streaming, reel, touch e via inglesizzando. Il risultato è stato buono: maggiore partecipazione di pubblico, sopratutto quello giovane; sviluppo di un metodo di comunicazione ad ampio raggio, coinvolgimento del “pubblico a casa” grazie alla possibilità di utilizzare gli strumenti per le video-conferenze e, soprattutto, adeguamento del museo stesso agli standard della museologia contemporanea. Bene. Ma, la domanda è: quanto può essere utile tutta questa meravigliosa tecnologia se, contestualmente, il museo manca dei mezzi basilari per la cura quotidiana delle sue collezioni? Dove sono finiti i bandi per la catalogazione del patrimonio sommerso? Dove si possono reperire i fondi per il restauro delle opere che richiedono consolidamenti? Come si può ottenere un finanziamento per la ristrutturazione dei depositi secondo le esigenze di una tutela necessaria?
Proiettare ogni istante della vita di un museo online, dandone una visione multimediale imbellettata dai trucchi del web,significa falsare la percezione di una realtà che, dietro il sipario di internet, rischia di deperire ignorata. È l’illusione di Matrix.
Se la parola “accessibilità” viaggia spesso abbinata a “sostenibilità”, facciamo in modo che il visitatore possa davvero fruire dell’esperienza museo a trecentosessanta gradi, stando seduto nel suo salotto, ma anche entrando nei caveau, guardando le sale con un visore, ma anche accarezzando le sculture con i guantini di cotone. Non i guanti biometrici dei supereroi con i sensori per simulare l’effetto materico di un marmo; ma i guantini veri del restauratore, pronto ad accompagnare i ragazzi nel retroscena dei laboratori, ad annusare la carta delle incisioni e gli smalti delle ceramiche. Lo ha fatto, per esempio, la Galleria d’arte moderna di Torino, con il suo nuovo progetto Il deposito vivente, che invita a percorrere sale tappezzate di rastrelliere e scaffali con opere numerate e schedate al fine di non essere dimenticate.
E lo vorremo fare noi del MAN, prendendoci cura delle oltre mille opere d’arte sarda (insieme al nucleo di opere della sezione contemporanea…) che meritano di essere custodite e mostrate, non solo attraverso un ologramma che le illustri in dieci lingue diverse e le materializzi nel palmo di una mano come la principessa Leyla di Guerre Stellari. Ma anche (finanziamenti permettendo!) semplicemente appese a un muro sano, con una luce corretta, una bella didascalia e il puro piacere reale dello sguardo che le osservi da vicino.
Chiara Gatti