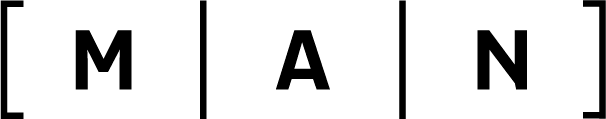Abiti che pesano: il debito ecologico e sociale del fast fashion
Il fenomeno del fast fashion rappresenta una delle contraddizioni più emblematiche del nostro tempo, un sistema in cui si intersecano dinamiche economiche, sociali e ambientali che perpetuano un circolo vizioso difficile da spezzare.
Dietro ogni capo a buon mercato, infatti, si cela un ciclo di sfruttamento intensivo della forza lavoro e di risorse naturali, emissioni massicce di CO2, sprechi d’acqua e rifiuti tessili che invadono ogni parte del mondo.
Per questo motivo, l’edizione 2025 di M’illumino di Meno, la campagna di sensibilizzazione promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio2, si concentra sulla necessità di ripensare il rapporto con la moda, puntando su modelli virtuosi di riuso e recupero creativo. Il MAN, sempre attento alle tematiche sociali e ambientali, aderisce con un programma che intreccia arte, educazione e consapevolezza.
Il fast fashion è il prodotto di un sistema economico che privilegia il profitto immediato a discapito del benessere collettivo, spingendo le persone verso l’overconsumption. La produzione intensiva, alimentata da manodopera sottopagata nei paesi in via di sviluppo, è una manifestazione di disuguaglianza sistemica che mette a rischio la salute del pianeta e la dignità umana. Ripensare questo modello significa promuovere una redistribuzione equa delle risorse, basata su principi di sostenibilità e giustizia.
Questo fenomeno non riguarda solo il consumo sregolato, ma anche lo spreco energetico. Ogni fase della produzione di un capo — dalla coltivazione del cotone alla lavorazione dei tessuti, fino al trasporto globale — implica enormi quantità di risorse. Il risultato è un ciclo rapido e insostenibile, dove i vestiti diventano rifiuti prima di esaurire la loro funzionalità.
Un esempio eclatante dei costi ambientali del fast fashion è la discarica del deserto di Atacama in Cile; qui, ogni anno, migliaia di tonnellate di abiti invenduti vengono abbandonati, danneggiando l’ecosistema locale. Un altro caso significativo si trova ad Accra, in Ghana, dove il mercato di Kantamanto è sommerso da scarti tessili provenienti principalmente dai paesi occidentali.
Questi esempi dimostrano come, nel sistema-mondo contemporaneo, i costi ecologici vengano “esternalizzati”, trasferiti dai paesi sviluppati al Sud Globale. Il concetto di debito ecologico, spiega chiaramente questa dinamica: i paesi responsabili delle emissioni e del degrado ambientale non ne subiscono le conseguenze dirette, che invece ricadono su comunità vulnerabili. Ma ciò che è nascosto non è mai davvero lontano.
Per molte persone scegliere abiti economici non è una questione di moda, ma di sopravvivenza. In un contesto in cui l’accesso all’abbigliamento sostenibile è spesso limitato da costi elevati e dalla scarsa distribuzione, il fast fashion diventa l’opzione più accessibile. In alcuni casi dunque, biasimare chi compra fast fashion è non solo ingiusto, ma miope, poiché ignora le cause strutturali che rendono questo fenomeno così diffuso e appetibile.
La riflessione che dobbiamo fare è profonda e collettiva: come possiamo creare un sistema che non sfrutti i più deboli, che non danneggi il pianeta e che, al contempo, rispetti le esigenze di chi vive con poche risorse?
Alessandro Moni
FONTI/APPROFONDIMENTI
Naomi Klein, No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies (1999)
Joan Martinez-Alier, The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation (2002)
Immanuel Wallerstein, The Modern World-System (Volumi I-IV, dal 1974 al 2011)
Elizabeth Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion (2012)
Dana Thomas, Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes (2019)
Nota all’immagine: Nel corso della mostra “Diorama. Generation Earth”, realizzata lo scorso anno, il museo MAN aveva esposto una importante opera d’arte contemporanea dell’artista portoghese Vanessa Barragão, fatta di filati di riciclo, frutto dell’industria della moda, in aperta denuncia contro sprechi e inquinamento.